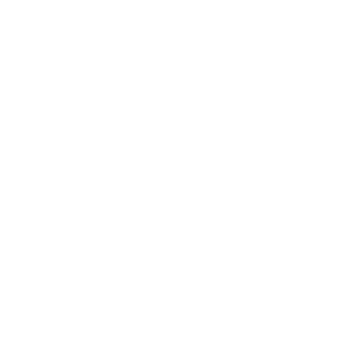Il maschio violento non è un “mostro”, non è una creatura diversa o lontana da noi, ma il risultato della normalità patriarcale che ha attraversato e, tuttora attraversa, la società, il linguaggio, le relazioni.
La percezione che chi commette violenza non possa essere un nostro collega, vicino di casa, amico o familiare allontana più facilmente la responsabilità della prevenzione, dell’essere individualmente e collettivamente consapevoli.
Secondo i dati dell’Osservatorio Non Una Di Meno, sono 76 i femminicidi avvenuti in Italia dall’inizio dell’anno.
Dalla casa al luogo di lavoro, dai trasporti pubblici ai luoghi di relazione, sia fisici che virtuali, gli stereotipi di genere continuano a condizionare e limitare la libertà e le opportunità di partecipazione delle donne.
La violenza economica, una delle forme di abuso più sottovalutate, è giustificata da un uomo su tre e considerata accettabile per la metà dei maschi Millennials e della Gen Z. Il 51% degli uomini gestisce da solo le finanze domestiche, contro il 38% delle donne, con divari più ampi tra i Boomers e nella Generazione X.
Il lavoro di cura continua a pesare prevalentemente sulle donne, il 41% delle madri si occupa da sola dei figli/e, contro appena il 10% dei padri. Il 52% delle donne a fronte del 35% degli uomini dichiara di aver provato paura negli spazi pubblici e la percentuale sale tra le più giovani.
È quanto emerge dal recente report “Perché non accada. La prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale”, realizzato da ActionAid insieme all’ Osservatorio di Pavia e 2B Research che hanno raccolto e analizzato i dati forniti da un campione di più di 1800 persone rappresentative della popolazione italiana.
La ricerca indaga i principali ambiti della vita quotidiana di ragazze e donne, mostrando come disuguaglianze di genere, stereotipi e squilibri di potere, siano pervasivi e radicati nella nostra società. Viene evidenziata inoltre la necessità che si riaccenda e avvii, oltre al dibattito, come quello che avviene ogni 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche un sostanziale e urgente cambiamento culturale.
Sì, perché è ancora lunga la strada da fare sia in termini di linguaggio che di politiche di genere.
A proposito di linguaggio, la narrazione mediatica dell’ennesimo femminicidio si basa su titoli spesso fuorvianti e dannosi come “uccisa per gelosia”, “l’amava troppo”, “non accettava la separazione”, e sulla scelta di immagini che ritraggono la vittima abbracciata all’aggressore, distorcendo la realtà e contribuendo a deresponsabilizzare chi uccide.
Sul fronte istituzionale, il Governo affronta il tema inseguendo la logica punitiva e securitaria.
A tutt’oggi, infatti, mancano interventi mirati e realmente trasformativi che guardino alla prevenzione primaria, mancano finanziamenti pubblici necessari al sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio, manca una rete territoriale efficiente che sostenga chi denuncia e chi vuole e deve poter ricominciare.
L’European Institute for Gender Equality (EIGE) ha evidenziato come i provvedimenti istituzionali realizzati nel nostro Paese per attuare e promuovere le politiche di uguaglianza di genere e d’integrazione della prospettiva di genere non siano sufficienti e ha assegnato all’Italia quest’anno un punteggio del 41.1 %, molto inferiore alla media dell’Unione europea.
Manca la volontà di incidere realmente sul mercato del lavoro dove la disparità retributiva pesa terribilmente sulle donne, con tassi di occupazione inferiori a quelli maschili, lavori precari, mal retribuiti, forme di part-time involontario che anziché strumento di conciliazione di vita e lavoro diventano strumenti di una flessibilità malata gestita da imprese che puntano a restare a galla anziché qualificarsi.
Emblematici in tal senso, sono i dati recentemente resi noti dall’Osservatorio Inps sull'occupazione e le retribuzioni del settore privato nel 2024, in cui si mette in luce come le donne abbiano ricevuto in media stipendi di 19.833 euro a fronte dei 27.967 euro medi degli uomini, il 29% in meno.
Un quadro poco edificante in cui ci troviamo immersi mentre è di questi giorni la notizia dell'approvazione alla Camera della proposta di legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di “consenso libero e attuale”. Qualunque atto sessuale attuato senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra il delitto di violenza. Una proposta di cui occorrerà seguire i passaggi parlamentari, ma che è in linea con i principali obiettivi della Convenzione di Istanbul.
Un passo avanti in termini di civiltà, certo, ma non basta.
Serve un Paese che decida di intervenire sulle cause, che sappia fornire gli strumenti adeguati fin dall’infanzia, partendo da un’educazione inclusiva, da una formazione consapevole, che faccia dei numeri delle vittime non facili strumentalizzazioni, ma leva decisionale e propulsiva affinché il mercato del lavoro sia in grado di creare pari opportunità e sviluppo, affinché ci siano infrastrutture sociali reattive, ma per farlo, insieme alla volontà, occorrono preparazione e competenza.