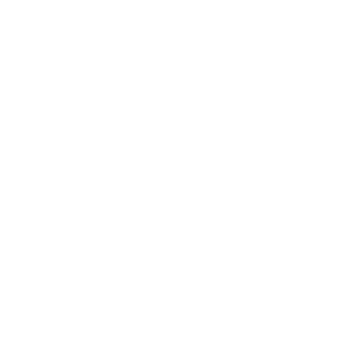La Corte Costituzionale inserisce fra i diritti inviolabili della persona il diritto all’abitazione, che «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988).
Il diritto alla casa è dunque strettamente legato all’inclusione sociale, strettamente legato al rispetto della dignità umana. Casa significa rifugio, riparo, spazio in cui poter rafforzare la propria crescita personale e attraverso il quale partecipare alla vita di comunità.
Negli ultimi anni il tema abitativo sta assumendo un’importanza macroscopica e trasversale, portando con sé i bisogni, le esigenze, gli ostacoli che interessano tanto i giovani quanto gli anziani, le famiglie e i soggetti in condizione di fragilità. Sì perché la questione abitativa è sfaccettata e si intreccia inevitabilmente con la precarietà economica, la marginalità sociale, le vulnerabilità sanitarie.
Dal recente Report Istat sulla povertà, che rileva quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia mediamente al di sotto della linea di povertà, nel 2024 le famiglie in affitto in condizione di povertà assoluta hanno superato il milione, con un’incidenza pari al 22,1%, a fronte del 4,7% rilevato tra le famiglie proprietarie e dell’11,5%, pari a 260mila famiglie, tra coloro che vivono in usufrutto o in uso gratuito.
Negli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2024, i prezzi delle abitazioni nell’Unione Europea hanno registrato un aumento medio del 53%, mentre i prezzi degli affitti sono saliti mediamente del 27,8 %.
In un Paese in cui oltre il 72% delle famiglie possiede la casa in cui vive e il 18% si trova in affitto, il peso del canone di locazione sul reddito familiare è ormai diventato una delle principali cause di impoverimento. Inoltre, sebbene il mutuo non rappresenti una spesa per consumo poiché considerato un finanziamento destinato ad accrescere il patrimonio immobiliare, per le famiglie costituisce un esborso rilevante pari a 581 euro medi mensili nel 2024, a fronte dei 567 dell’anno precedente.
Nonostante l’urgenza di politiche strutturali che affrontino la questione abitativa, il tema casa resta troppo spesso marginale nelle agende politiche nazionali e regionali quando non affidato a interventi di scarso respiro.
In Umbria, la questione si inscrive in modo evidente all’interno dei cambiamenti demografici e territoriali segnati dall’indebolimento del tessuto socio-economico e dalla contrazione della popolazione, che è passata da 892.099 abitanti nel 2014, agli attuali 851.954.
A questo va aggiunto che gran parte dei comuni regionali, 60 su 92 totali, rientrano nelle cosiddette aree interne, territori che, pur avendo beneficiato della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e dei fondi del PNRR, per migliorare l’accesso ai servizi, in molti casi hanno risentito di un problema strutturale di efficacia e coordinamento delle politiche pubbliche.
Alla grande disponibilità di patrimonio immobiliare in disuso nelle aree interne si somma la difficoltà di trovare casa nei centri urbani. Un fenomeno che porta ad alimentare fragilità e disuguaglianze, rese più marcate da una governance e una burocrazia spesso frammentate e da una carenza di investimenti infrastrutturali mirati, fondamentali per poter ridurre l’isolamento territoriale.
Poter disporre di un’abitazione significa non solo potervi accedere ma anche essere in grado di affrontarne le spese di mantenimento e dunque l’incidenza dei costi sul reddito.
Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riportati dall’ente camerale, il reddito complessivo Irpef per contribuente in Umbria è aumentato del 10,8% in termini nominali tra il 2019 e il 2023, una crescita inferiore alla media nazionale del 13,9%. Un quadro ancor più critico se si considera anche l’inflazione: in termini reali, il reddito medio umbro è infatti diminuito del 3,7%, contro un calo medio italiano dell’1%, generando una perdita pro capite in potere d’acquisto pari a 865 euro.
Mentre a livello nazionale il Piano Casa annunciato finora appare un guscio vuoto e manca da tempo una programmazione organica, a livello regionale qualcosa sembra muoversi.
La Regione ha infatti recentemente annunciato la volontà di avviare un piano pluriennale di manutenzione e rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico, con un investimento previsto di almeno 10 milioni di euro l’anno, per restituire agibilità agli alloggi oggi inutilizzabili.
In Umbria, infatti, su circa 7.800 appartamenti affittati, oltre 1.600 risultano non locabili a causa delle carenze manutentive accumulate negli anni.
A complicare il quadro vi sono un elevato turnover degli inquilini, la morosità accumulata di oltre 12 milioni di euro e l’aumento delle riconsegne di alloggi (da 100 a più di 200 l’anno), in parte dovuto all’impatto della riforma ISEE e alle difficoltà economiche crescenti.
Dalla Giunta regionale arriva anche l’impegno a ripristinare i fondi per la morosità incolpevole e per l’acquisto della prima casa delle giovani coppie, così come la volontà di promuovere modelli abitativi innovativi come co-housing e social housing.
Occorrerà dunque mettere le gambe agli impegni traducendo i progetti in obiettivi di responsabilità condivisa.
Redazione Nuove Ri-Generazioni Umbria